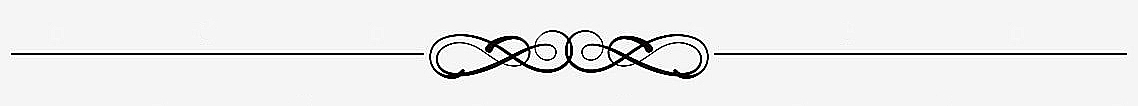Senza nome – di Ernesto Flisi


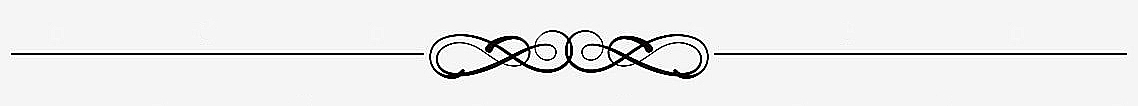
Senza nome – di Ernesto Flisi
Faceva un freddo terribile in quel gennaio del 1864. Aveva nevicato molto; poi era seguito un tempo di gelo come non si ricordava, con temperature che nella notte scendevano sotto i 25-30°. Le strade, per lo più sterrate (le migliori), rese spesso impraticabili anche ai carretti trainati da cavalli o da asini, erano ricoperte di neve gelata, indurita, al punto da rendere molto difficile il percorso anche a persone a piedi che a stento di notte riuscivano a distinguere il sentiero dai fossi laterali. Difatti non c’era anima viva che si spostasse, di giorno e tantomeno di notte. E anche se ci fossero state urgenze (un malato, un morto) chi si poteva arrischiare a tirare fuori dalla stalla un asino, un bue o (per i più abbienti) un cavallo per trasportare qualcuno? Era più che mai a rischio la sopravvivenza non solo dei trasportati, ma anche degli animali.
Il paesaggio della campagna era spettrale e di notte in aperta campagna si sentivano dei forti scoppi, che i vecchi contadini capivano provenissero da tronchi delle piante che, impregnate d’acqua e di gelo, scoppiavano con rumore; anche i fusti contorti delle viti vecchie ne erano coinvolti. Certo le piante dei filari, in riva ai fossi, se scoppiavano, difficilmente sopravvivevano. Almeno però in primavera si poteva fare legna. Le viti danneggiate, invece, costituivano un danno enorme. La viticoltura nella Bassa costituiva un settore tra i più vitali della locale produzione agricola.
Un’urgenza però c’era in quella notte terribile. All’una Giuseppone, il campanaro, fu svegliato dalla perpetua del parroco, che aveva battuto ripetutamente con un palo agli scuri della sua stanza, posta sotto il campanile. Per un po’ Giuseppone non rispose, poi pensò, nel dormiveglia, a dei ladri o a dei malintenzionati. Fatto sta che l’insistenza dei colpi lo costrinse a scendere dal letto, ad alzarsi nel gelo di quella stanza, dove il fiato si trasformava presto in gocce gelate e aprire uno scuro. Al chiarore della neve e della luna vide una sagoma nera che con voce femminile, ma senza urlare, chiedeva di scendere subito. “Ma siete voi Argìa? Ma cos’è successo?”. “Don Ippolito vi vuole subito in canonica, presto! Non c’è tempo da perdere. E’ urgente”. Giuseppone avrebbe voluto protestare, capire qualcosa, ma Argìa, avvolta nel suo scialle nero, unica cosa che la faceva identificare nel biancore della neve, non gli dette tempo; era già tornata in canonica.
Il povero campanaro avrebbe mandato al diavolo di cuore sia la perpetua che il prete, ma non se lo poteva permettere. Chi gli avrebbe dato un lavoro pagato poco, è vero, ma sicuro, rispettato in paese? Inoltre poteva beneficiare dei proventi delle questue che raccoglieva il parroco quando lo accompagnava a benedire le case e le stalle, qualche soldo poi lo ricavava dai battesimi, dai funerali, dai matrimoni. E chi era bravo a suonare le campane come lui? Certo, la parte più cospicua andava a don Ippolito, ma una parte rimaneva anche a lui. Insomma qualche salame, un po’ di burro e qualche uovo lo rimediava. Inoltre curava l’orto del parroco e qualche verdura pure capitava sulla sua tavola. Quindi proprio doveva scendere al freddo e recarsi in canonica. Si vestì coi suoi stracci, calzò le sue sgalmare chiodate e si coprì con un gran tabarro che, anche se un po’ logoro (era già stato di suo padre), riparava bene dal freddo.
La canonica era a una decina di metri, vide la porta socchiusa e scorse una sottile lama di luce che proveniva da una candela accesa nello studio del parroco. “E’ permesso?”, chiese. Dall’interno udì la risposta immediata di don Ippolito:” Entra, fai presto!”. Nella stanza c’era anche la perpetua che squadrò con un’occhiata il suo trasandato campanaro, ma, nonostante la lingua lunga, non proferì parola. Neanche Giuseppone però ebbe tempo di chiedere cosa era successo. Nella stanza regnava
un silenzio indecifrabile, che fu interrotto subito però dal parroco:”Devi portare questo bambino subito alla ruota a Viadana” e gli indicò una cesta di vimini, posta a terra; si trattava di una cavagna (così la denominavano al tempo). Era una cesta con manico, simile a quelle che le contadine utilizzavano per la vendemmia. Dentro vi era un neonato, coperto da stracci di lana che svolgevano la funzione di panni. Al collo aveva appeso un nastrino rosso con una medaglietta della Madonna spezzata a metà. Sembrava tranquillo, dormiva.
“Ma reverendo non si può andare domattina? C’è un freddo cane e da qui a Viadana ci sono 12 chilometri e a percorrerli a piedi e poi con questa cesta, non so quante ore ci vorranno; le strade sono ghiacciate. Di giorno almeno so orientarmi, ma di notte, con la neve e il ghiaccio che ricoprono tutto, potrei anche sbagliare direzione”, tentò di obiettare Giuseppone. Don Ippolito però non ammise repliche. “Avrai anche un compenso, ma è assolutamente urgente che il bambino sia consegnato nella Pia Casa Esposti”.
Lo sguardo arcigno dell’Argìa era più che mai eloquente.
Così al povero campanaro non restava altro da fare che indossare subito i suoi guantoni di pezza, stringersi bene al collo la sciarpa, calare sulle orecchie le tese del suo cappello di lana, avvolgere il più possibile il suo tabarro e partire.
Era un’avventura, in quelle condizioni atmosferiche, recarsi da Dosolo (questa era la parrocchia di don Ippolito) a Viadana, il paese principale del distretto, dove c’era l’Ospedale e l’annessa Casa Esposti.
Comunque all’una e mezza il buon campanaro era già in viaggio. Sulle prime sentiva un vento gelido in faccia, ma poi, camminando, un po’ si scaldò. Per non sbagliare strada, teneva d’occhio le sagome fosche dei pioppi che delimitavano le proprietà confinanti con la strada verso Viadana, ma non distingueva i campanili dei paesi che incontrava. I paesi e le cascine erano come scomparsi. Il solo rumore era quello delle sue scarpe chiodate che crocchiavano sul ghiaccio che ricopriva le strade. Solo, di tanto in tanto, sentiva in lontananza qualche latrato di cane. Non incontrò nessuno, ovviamente, se non altro per chiedere se la strada era giusta, ma non ci sperava molto.
Il bambino dopo un’ora circa si era svegliato e piangeva. Giuseppone però non sapeva come fare per acquietarlo; oltretutto lui non aveva mai avuto bambini e poi sarebbe stato incapace di gesti affettuosi o di tentativi di cullare il neonato. L’unico movimento era quello della cesta, che oscillava con i movimenti della sua camminata o con qualche scivolone sul ghiaccio. Per fortuna il campanaro era di fisico solido e ben piantato, come dicevano i contadini del suo paese. Le sue mani, più che alle carezze, erano abituate a stringere le funi delle campane. Pensò che il bambino piangesse per il freddo, ma non sapeva cosa fare, se non accelerare il passo. La fatica però, con quel freddo e con quel ghiaccio, gli rendeva impossibile l’intento. Anche le ciglia sembravano ghiacciarsi. Intanto nella sua testa frullavano alcune domande: chi era la madre del bambino? E il padre? Perché lo portava alla ruota? Cosa sapeva don Ippolito? Perché avevano portato l’infante in canonica? Non dubitava certo del suo parroco; forse si trattava di qualche giovane donna al servizio del notaio o di qualche ricco possidente del paese. In tal caso lo portavano alla ruota per nascondere una maternità compromettente. O forse la madre era la moglie di qualche poveraccio, già carico di prole, che proprio non poteva immaginare come sfamare un’altra bocca. E mentre rimuginava tra sé
e sé questi pensieri, il pianto del bambino piano piano cessò. Giuseppone pensò che si fosse addormentato. Meglio così.
Passò Correggioverde, poi Pomponesco, il minuscolo paese di Banzuolo, la corte dei Tre Santi e quando cominciava ad albeggiare era quasi a Buzzoletto, a pochi chilometri da Viadana. Non sapeva che ora fosse, ma visto il primo chiarore, pensò che fossero appena passate le 6 o le 7. Quando arrivò alle prime case del Carrobbio, all’inizio dell’abitato di Viadana, sperava di trovare qualche carrettiere, qualche sellaio, magari un’osteria per bere un goccio di vino e scaldarsi un po’, ma niente: sembrava un paese fantasma. Però poi sentì suonare le campane di S. Pietro, poi quelle del Castello, di Santa Maria e quindi si diresse verso quello scampanio, convinto di arrivare al centro del paese: là ci sarebbe stato l’Ospedale e là avrebbe depositato il neonato.
Nei pressi delle chiese non vide le donne recarsi alla prima messa: troppo freddo? E chi se la sentiva di uscire? Ne sapeva qualcosa anche lui, che allo stesso orario si attaccava alle funi delle campane per suonare l’Ave Maria e poi i richiami per la messa del mattino, ma in quelle settimane vedeva al massimo due o tre vecchie recarsi in chiesa.
Arrivato quasi al centro del paese, trovò due gendarmi, riparati sotto un portico. Lo fermarono e gli chiesero dove stesse andando. Giuseppone, che era analfabeta, in dialetto e in soggezione dei militari, proferì qualche parola, ma riuscì a far capire quale era il suo scopo. Lo lasciarono andare subito, indicandogli la strada per arrivare a destinazione. Non ebbero il coraggio di scoprire gli stracci e verificare se il loro interlocutore fosse un furfante oppure un povero diavolo che compiva un gesto pietoso. Bastava guardarlo in viso Giuseppone, per capire. Del resto solo alzare gli stracci che nascondevano il bambino poteva essere dannoso per lui.
Al termine dei portici del Borgo San Francesco c’era l’Orfanotrofio Femminile; girò a sinistra e vide la chiesa di Sant’Anna. Si ricordò delle indicazioni date da don Ippolito. A fianco di Sant’Anna vi era l’ingresso dell’Ospedale. Tra i due edifici era ancora accesa una torcia notturna che illuminava la ruota. Si guardò intorno circospetto, perché nessun curioso lo vedesse o gli facesse domande strane, alle quali peraltro avrebbe avuto qualche difficoltà a rispondere. Poi estrasse il bambino e, senza tanti dubbi, lo adagiò nella cavità della ruota; la girò, azionando una maniglia, poi tirò un filo a penzoloni che permetteva di far suonare una campanella. Sentì i rintocchi nervosi all’interno. Era il segnale per le suore dell’Ospedale che c’era un nuovo esposto.
Giuseppone si sfilò subito, riprendendo i portici che aveva percorso poco prima in senso contrario e camminò svelto, cercando di non dare nell’occhio a nessuno. Già c’erano alcuni artigiani che aprivano bottega: un sellaio, un maniscalco, un calzolaio, un falegname, un fornaio (uh che voglia avrebbe avuto di entrare a prendere una forma di pane!), ma continuò a camminare spedito fino al Carrobbio. Qui, vista l’insegna di un’osteria, cedette alla tentazione e alla fame. Entrò, non c’era nessun avventore. Intravide però, alla luce delle candele, un oste corpulento. Chiese di avere una scodella di trippe, una rosa di pane e un’altra scodella di lambrusco. Insomma una colazione che allora si consumava nelle osterie e Giuseppone ne sentiva un gran bisogno. L’oste lo squadrò con sguardo indagatore e poi, non sapendo chi era, mentre lo serviva, gli chiese a bruciapelo:” Da dove venite? E che ci fate con una cavagna vuota?”. Il campanaro, subito fattosi rosso in viso, rispose che veniva da Banzuolo e aveva portato verze e uova in un palazzo signorile del centro di Viadana. L’oste rispose con un :”Ah”, detto a mezz’aria, ma senza troppa convinzione della risposta.
La fame di Giuseppone però era tanta e divorò le trippe calde, nelle quali aveva inzuppato la rosa di pane e bevve in solo due sorsi tutta la scodella di vino. Pagò in fretta e poi uscì. Per sua fortuna c’era ben poca gente in giro e sulla strada per Dosolo trovò pochissime persone: tre o quattro in tutto.
Così alle 12,30 fu in canonica da don Ippolito. La perpetua, col mestolo in mano, stava versando una minestra fumante in una fondina davanti al parroco. Questi gli chiese subito se tutto era andato a posto e il campanaro annuì, senza proferire parola, ma indugiando un po’ davanti al parroco, già seduto a tavola. L’indugio era dovuto al desiderio di potere anche lui gustare quella minestra di brodo di gallina che lo avrebbe scaldato un po’ (e Dio sa quanto ne sentisse il bisogno), ma anche alla necessità di riscuotere il compenso promesso. Don Ippolito, che lo conosceva bene, intuì subito e disse:” Argìa, dai a Giuseppone quei soldi che sono nel primo cassetto a destra della mia scrivania”. La perpetua, con un cenno della testa, si trascinò dietro il campanaro nel corridoio, dicendogli: “ Stai qui che arrivo”. Dopo una manciata di secondi, fece sfilare nella mano di Giuseppone alcune monete, che equivalevano a poco più del doppio di quelle che aveva speso in osteria. Senza obiettare nulla, il campanaro ringraziò e rientrò a casa.
All’Ospedale invece, suor Carolina, che era addetta per turno quella notte a ricevere gli esposti, appena suonata la campanella, corse alla ruota e prese il bambino avvolto negli stracci e, come d’abitudine, stava precipitandosi nella attigua chiesetta di Sant’Anna per farlo battezzare subito , ma per la sua curiosità non resistette dal guardarlo. Tolto il primo panno però si accorse che le mani del bambino erano gelide, il viso cianotico e il corpo rigido: era morto per il freddo.
Corse ugualmente a cercare la suora superiora, che era inginocchiata su uno sgabello in chiesa, intenta a leggere un libro di preghiere e le chiese il da farsi. Quella non ebbe dubbi: “Va seppellito nella fossa comune”. Era un vano scavato sotto terra, ricoperto da un gran piastrone di pietra posto nel piazzale antistante la chiesa di Sant’Anna . Lì venivano sepolti anche i malati deceduti nell’Ospedale e che erano nullatenenti, senza una famiglia che si curasse del funerale. A questi deceduti comunque veniva impartita una breve cerimonia religiosa; erano cristiani e non si potevano seppellire come animali.
Al bambino portato da Giuseppone no, perché non essendo stato battezzato, non si poteva celebrare il rito di suffragio. Così sul registrone di tutti gli esposti fu annotato il fatto, ma senza attribuire un nome al bambino.
Quella madre che aveva deciso, probabilmente costretta, a farlo portare alla Pia Casa Esposti e che aveva trattenuto l’altra metà di quella medaglietta che aveva appeso al collo del bambino, nella speranza, remota, di poterla un giorno esibire per dimostrare che era suo figlio, qualora fosse stata nelle condizioni economiche di poterlo riavere con sé, in realtà non ne seppe più nulla.
Né furono mai avanzate richieste alla direzione della Pia Casa Esposti .
(questo racconto ha ha vinto il primo premio ex-aequo al IV Concorso “Nascere e rinascere” di Cologna Spiaggia (TE) nel dicembre 2023)