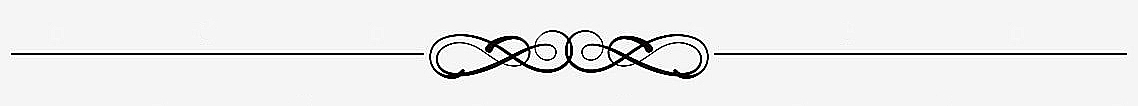1° maggio – di Giampietro Lazzari


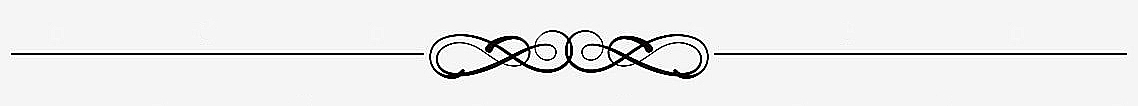 Un primo maggio speciale. Festeggiato il giorno prima, con un racconto. Volevamo trovare qualcosa di speciale anche quest’anno. Perché la tradizione, il deja vu un pochino ci annoiano da sempre. A darci una mano è stato lo scrittore più intimista e malinconico che, in questi anni, abbiamo avuto modo di scoprire. Uno straordinario alchimista della parola che con semplicità racconta episodi di vita vissuta. Poco importa che siano i suoi, perché leggendoli, per noi che i 50 li abbiamo superati, diventano pure i nostri. Stesso clima, stesse emozioni, stesso stretto legame con le cose e le persone, con quello che era un tempo di amicizia, di dolore, di gioia di stare insieme, di perdite e di ritrovi. Questo è Giampietro Lazzari, un amico del nostro lavoro che di tanto in tanto ci chiede se c’è bisogno di un suo racconto. E a noi – un poco – viene da ridere. C’è sempre bisogno di un racconto, e di un suo racconto, di un ricordo, di emozioni. C’è sempre di leggere qualcosa in grado di toccare l’anima. Sempre bisogno di quiete, di moto, di pace, di luce e di ombre. C’è sempre bisogno di parole, e ancor più come le sue. Non siamo (e soprattutto io non sono) un purista del giornalismo. La cronaca, la politica, l’economia è importante ma è importante pure dare al lettore qualcosa con cui confrontarsi, qualcosa per cui emozionarsi, qualcosa magari da cui apprendere. Qualcosa da leggere con godimento. Giampietro ha questa capacità. Cercavamo qualcosa di originale per il primo maggio e lo abbiamo trovato. E se avete racconti – almeno sino a che ci sono e ci siamo – mandateceli pure. In qualche modo e in qualche tempo troveremo spazio anche per loro. Grazie Giampietro, e buon primo maggio in anticipo a tutti. Oglioponews è anche questa cosa qui: un contenitore di parole in cui i racconti sono i benvenuti. Sempre. (NC)
Un primo maggio speciale. Festeggiato il giorno prima, con un racconto. Volevamo trovare qualcosa di speciale anche quest’anno. Perché la tradizione, il deja vu un pochino ci annoiano da sempre. A darci una mano è stato lo scrittore più intimista e malinconico che, in questi anni, abbiamo avuto modo di scoprire. Uno straordinario alchimista della parola che con semplicità racconta episodi di vita vissuta. Poco importa che siano i suoi, perché leggendoli, per noi che i 50 li abbiamo superati, diventano pure i nostri. Stesso clima, stesse emozioni, stesso stretto legame con le cose e le persone, con quello che era un tempo di amicizia, di dolore, di gioia di stare insieme, di perdite e di ritrovi. Questo è Giampietro Lazzari, un amico del nostro lavoro che di tanto in tanto ci chiede se c’è bisogno di un suo racconto. E a noi – un poco – viene da ridere. C’è sempre bisogno di un racconto, e di un suo racconto, di un ricordo, di emozioni. C’è sempre di leggere qualcosa in grado di toccare l’anima. Sempre bisogno di quiete, di moto, di pace, di luce e di ombre. C’è sempre bisogno di parole, e ancor più come le sue. Non siamo (e soprattutto io non sono) un purista del giornalismo. La cronaca, la politica, l’economia è importante ma è importante pure dare al lettore qualcosa con cui confrontarsi, qualcosa per cui emozionarsi, qualcosa magari da cui apprendere. Qualcosa da leggere con godimento. Giampietro ha questa capacità. Cercavamo qualcosa di originale per il primo maggio e lo abbiamo trovato. E se avete racconti – almeno sino a che ci sono e ci siamo – mandateceli pure. In qualche modo e in qualche tempo troveremo spazio anche per loro. Grazie Giampietro, e buon primo maggio in anticipo a tutti. Oglioponews è anche questa cosa qui: un contenitore di parole in cui i racconti sono i benvenuti. Sempre. (NC)
PRIMO MAGGIO (di GIAMPIETRO LAZZARI)
I tratti del suo viso ricordavano il muso di un gatto, ed infatti da sempre noi lo chiamavamo così: Il Micio. In verità in paese a quel tempo di Micio ce n’erano almeno tre: Un Micio grande – detto Micione – il Micio nostro coetaneo ed un Micio giovane. Quel soprannome del resto era molto diffuso dalle nostre parti.
Naturalmente noi ancor oggi quando diciamo “Micio” intendiamo il secondo, il nostro amico. Quindi se dobbiamo riferirci ad un altro Micio dobbiamo dire: “… non il Micio Micio, l’altro Micio… e far seguire l’ulteriore specifica per indicare uno dei due restanti. Chiaro no? Oddio a dirla tutta esisteva anche un quarto Micio, ma era uno originario delle frazioni e quindi non contava. Ma ora non stiamo a sottilizzare.
Il Micio era un personaggio particolare. Fin da ragazzo la sua personalità alternava tratti da simpatico fanfarone a straordinari slanci di vitalità. Una cosa però era certa, amico mio: il Micio era un gran giocatore di carte ed un venditore nato. Noi avevamo imparato a non cadere nelle sue trappole sul tavolo verde e meno ancora a quelle commerciali, ma chi non lo conosceva ne rimaneva ammaliato. Avrebbe potuto vendere i ghiaccioli agli Inuit, come si suol dire.
Ed infatti il lavoro lo vedeva eccellere nel mondo dei rappresentanti di commercio. Macinava migliaia di chilometri, incontrava moltitudini di persone, firmava pile di contratti senza soluzione di continuità. E così per molto tempo.
Poi un giorno, complice l’insostenibilità di quel ritmo forsennato e una delusione d’amore, il Micio si fermò di colpo, passando in un solo istante dalla velocità della luce all’immobilità di un fermo immagine. Disse che se ne sarebbe andato, in un paese ad una sessantina di chilometri da qui, dichiarando che avrebbe coltivato patate. Si trasferì quindi a ridosso delle colline, in un rudere di campagna che un giorno fu del padre, mai conosciuto poiché morto quando lui era in fasce. Disse anche che avrebbe ricostruito il rudere e che avrebbe condotto una vita riservata.
Nessuno avrebbe scommesso sul Micio contadino né credo mai nessuna patata sia nata in quel terreno che circondava la casa. Fu così comunque che il nostro amico sparì e per qualche tempo non ne sapemmo più nulla.
Passò qualche anno ed un giorno – non ricordo bene il perché – si decise di andare a vedere che fine avesse fatto il Micio. Partimmo dunque e con un po’ di fatica arrivammo in quella casa isolata nella campagna. Beh, casa era dire molto. Anticamente probabilmente era stata una discreta dimora di campagna, ma in quel momento appariva più una stamberga che qualcuno stesse cercando di puntellare per poterci vivere dignitosamente.
Si presentò ai nostri occhi un’aia abbastanza grande, tipica delle case coloniche. Avanti a noi la struttura principale su due piani, decisamente mal messa. A destra i bassi servizi e i locali che un tempo avevano ospitato gli animali da cortile. A sinistra il portico per il ricovero degli attrezzi, più a lato una singolare piccola costruzione somigliante ad una torretta antica, ancora più in malora.
Un simpatico cane – dalle sembianze di una mortadella più che di un amico dell’uomo – ci accolse abbaiando stancamente. Poi da un una finestra senza telaio venne fuori il Micio. Dimagrito, con indosso una salopette consunta da casa nella prateria riconoscemmo però che non aveva perso quello sguardo sfavillante del tempo in cui aveva cavalcato la velocità.
Ci abbracciamo e dopo aver bevuto qualcosa ci mostrò quella sua dimora che stava rimaneggiando. Di patate comunque neanche l’ombra. Mentre ci aggiravamo fra mattoni vecchi, puntelli di legno ed attrezzature improbabili qualcuno disse: ”Ehi Micio,ma sai che qui potremmo fare il Primomaggio?”
Il primomaggio altro non era che un ritrovo per la solita grigliata. Ma fino ad allora era un frangente che vedeva coinvolte non più di una decina di persone e che nel giro di poche ore trovava inizio e fine. – Ne sarei veramente contento – disse il Micio – organizzate pure; io ci metto il posto; chiamate chi volete, venite all’ora che volete, andate via quando volete. Un’unica cosa: se sono a letto non svegliatemi. Per il resto non c’è nessuno problema.
Per il Micio del resto non c’era mai stato nessun problema. Nemmeno quella volta che, abbattuta una cabina del telefono, gli si era staccato il motore dal telaio dopo che aveva tentato un’ardita elaborazione sulla sua 127, da noi battezzata La bat-mobile.
Fu così che ebbe inizio quella tradizione di festeggiare il giorno dei lavoratori in quella campagna lontana con la presenza di tutta la compagnia e di altre persone che nel tempo si avvicendarono. Già dai primi anni il numero dei partecipanti si era fatto cospicuo ma in poco tempo crebbe fino a diventare quasi ingestibile. Già all’inizio del mese precedente l’evento si iniziava la conta dei presenti e degli assenti avuto riguardo all’anno prima ed alle meteore che via via apparivano nel cielo del gruppo consolidato.
Avevamo imparato così bene a gestire coloro che avevano giurato che sarebbero venuti per poi dare buca e quelli che, senza invito, si sarebbero presentati all’ultimo momento, che eravamo in grado di stimare con esattezza il reale numero, e quindi, amministrare il vero cuore della circostanza: le derrate alimentari.
L’acquisto infatti in primis della carne, delle verdure, ma poi di tutto il resto che necessitava a sfamare quella moltitudine – oltre naturalmente ad una quantità importante di bevande – era attività fondamentale. E qui si scatenavano le prime schermaglie che in ogni parte del globo dividono gli uomini in molte delle loro manifestazioni. C’erano i puristi, che al motto “è una grigliata!” avrebbero voluto solo salamelle e pane, e forse nemmeno il pane. Poi c’erano gli indecisi che non sapevano mai cosa proporre e cambiavano idea ogni piè sospinto, viaggiando tra il “solo pane e salame” a un “tris di primi”. Non mancavano gli chef ante moda, che optavano per novità esotiche e decisamente costose. Gli ultimi anni fecero la loro comparsa pure i vegetariani che ad una grigliata sono sempre un po’ fastidiosi. I vegani non avevano ancora fatto comparsa nel nostro mondo.
Alla fine tanto eravamo sempre noi che decidevamo: io, il Ludo, e La Vecchia; più uno dei due fuochisti che, per naturale competenza, aveva diritto di espressione. Solo che abbracciavamo teorie economiche diverse. Io piuttosto social-conservatore, tendevo ad una spesa oculata per non fare lievitare la quota di partecipazione. Il Ludo, di formazione più liberista, affermava che la legge di mercato avrebbe risolto tutto. La Vecchia, in mezzo a noi, dispensava perle di vetero saggezza, dall’alto dell’esperienza di anni di grigliate in altre compagnie. Il fuochista fingevamo di ascoltarlo. Annuivamo quando parlava ma mai facevamo come diceva.
Dopo discussioni che duravano intere serate arrivavamo finalmente ad una decisione. Tra salamelle, pancette, spiedini, costine, pollastrini, salumi, formaggi, antipasti, verdure di ogni specie e contorni vari, trovavamo una quadra. Con quella chiarezza si sarebbe potuto ordinare la carne ad un fidato macellaio del luogo e, il giorno prima dell’evento, rifornirsi di tutto il resto avvalendosi di alcuni amici che avremmo assoldato con l’incarico di sherpa.
Quando uscivamo dal supermercato dopo aver acquistato tutto il necessario sembravamo più un equipaggio di un veliero in partenza per le Nuove Indie piuttosto che gente che doveva fare una grigliata. Quasi quasi alle casse ci aspettavamo che scattasse l’applauso. Poi accadeva che fra i generi acquistati ci dimenticassimo sempre di qualcosa di essenziale ed all’atto di svuotare i carrelli nei bauli comparisse invece sempre qualcosa di totalmente inutile per una grigliata per decine di persone come lacca per capelli o una sola minuscola confezione di succedaneo di caviale. Stranezze degli acquisti collettivi pensavamo.
La mattina del Primomaggio si partiva presto, quanto meno noi organizzatori. Avremmo dovuto fare un po’ di strada, fermarci in un paio di bar, arrivare nella cascina, scaricare la montagna di derrate e montare tutta la tavolata orizzontale che si estendeva per l’intera lunghezza trasversale dell’aia. Insomma non poche cose e tutte molto importanti. Il materiale per costruire la tavolata e le panche era già sul posto. Vecchie cassette da uva impilate a formare cavalletti e casseri da muratore più altre assi in legno ci avrebbero consentito di realizzare un desco popolare sì, ma appropriato. Il tutto veniva poi coperto a mo’ di tovaglia con carta da parati anni ’70, rimasuglio di chissà quale improvvido acquisto, per cui le superfici risultavano per lo più psichedeliche e dopo che il sole ti aveva battuto sulla testa per qualche ora provocavano qualche giramento. O forse era il vino, non so.
Esaurite con impegno quelle incombenze, e prima che arrivasse la moltitudine – finalmente – ci sedevamo, soli, a metà del tavolone. E davanti alla prima bottiglia e ad un generoso pezzo di grana, ci godevamo l’inizio di quel bel giorno che, ancora una volta di lì a poco, saremmo riusciti a donare agli altri ed a noi stessi. Ed eravamo contenti.
Verso il termine della mattinata, come sciami di api, incominciavano ad arrivare le persone. Singoli, coppie stabili, gruppetti storici, nuclei familiari completi, amici, amici degli amici, conoscenti, sedicenti amici del Micio, sconosciuti. Insomma una varia umanità ruzzolante sul quell’aia che piano piano, secondo un ordine determinato da imprevedibili ragioni sociologiche, trovava il proprio spazio lungo tutta quella tavolata.
La tavola era talmente lunga che capitava che quando coloro che erano seduti in testa intendevano andare verso coloro dalla parte opposta, sembrava partissero per un viaggio da parenti, tanto che si portavano dietro tutto quanto. Bicchieri, piatti, sigarette.
I primi anni meno, ma dopo qualche tempo cominciarono a fare la propria comparsa anche infanti e altri piccoli uomini. E divennero sempre più una presenza stabile ed anche apprezzata. Finché erano molto piccoli questi venivano rinchiusi in una specie di stabbio che nello stesso tempo li proteggeva dai pericoli circostanti e fungeva da area di gioco. Buttavamo dentro due pupazzi ed un paio di pallette ed il gioco era fatto. Si sarebbero divertiti come matti sporcandosi e scatenandosi nella paglia, per poi addormentarsi nel primo pomeriggio. Del resto – amico mio – mi capirai. Se li avessimo lasciati liberi – questi piccoli esseri alti come un paracarro – sarebbero potuti sfuggire all’attenzione delle madri e lanciarsi nel grano circostante facendo repentinamente perdere le proprie tracce fra le spighe fruscianti. E ciò – concorderai – avrebbe potuto destabilizzare il clima festoso.
Un cenno particolare, caro amico – vorrei riservartelo ai due fuochisti, quelli che materialmente, per tutta la giornata alimentavano la grande griglia che sfamava tutte quelle bocche voraci. I primi anni questa altro non era che un buco nella terra riempito di braci, sul quale veniva appoggiata la vera e propria griglia di metallo. Dopo qualche anno essa venne sostituita da una realizzazione in ferro brunito costruita da uno dei fuochisti, esperto fabbro. Per la sua imponenza appariva un oggetto tra un simulacro di una divinità pagana ed il toro di Falaride. Quattro enormi gambe sostenevano un mezzo cilindro ricavato da un bidone di petrolio tagliato longitudinalmente nel quale alloggiavano le braci vive, e saldata sopra una smisurata griglia in acciaio lucente, completa anche si scomparti a lato. Essa consentiva di cuocere contemporaneamente molti pezzi. L’area intorno alla griglia era simile ad un girone infernale e chi si avvicinava veniva il più delle volte scacciato dai due demoni con brusche maniere.
I fuochisti erano due personaggi strani. Antitetici già a partire dal loro stesso nome che era l’uno l’anagramma dell’altro. Uno Enzo, l’altro Zeno. Enzo era piccolo, tracagnotto e bianchiccio mentre Zeno era alto, abbronzato e prestante come una statua greca. Entrambi si accingevano al loro compito con modalità e ritmi discordanti. Zeno già dal primo mattino stava nudo dalla cintola in su; Enzo stava imbacuccato in una giacca imbottita ed indossava pure una sciarpa e un buffo cappelletto da ferroviere, e così rimanevano fino a sera, entrambi dicendo che era quello il modo corretto per affrontare il calore in prossimità del fuoco.
La cosa particolare è che ognuno tendeva a disfare ciò che l’altro stava compiendo; tanto che spesso ci siamo chiesti per quale prodigio alla fine riuscissero sempre a dar da mangiare a tutti i convenuti. Enzo preparava la carbonella, Zeno la toglieva; Zeno metteva sulla griglia le salamelle; Enzo le spostava per far cuocere le zucchine; Enzo, sventolando un cartone, faceva vento per attizzare le braci, Zeno col badile le toglieva dicendo che la carne stava bruciando; e così via. Insomma le cose andavano così. Però a tarda sera, quando molte ore di griglia li avevano dipinti di scuro e sembravano caldaisti di un transatlantico, era bello osservarli, uno accanto all’altro nell’ombra lunga del tramonto, che fumavano e si facevano i complimenti per il risultato che – devo ammettere – è sempre stato lusinghiero.
E così si dipanava la giornata, almeno fin quando c’era luce. Una festosa congrega vociante stesa lungo quel tavolone che, senza sosta, si cibava delle preparazioni dei fuochisti e di tutto quanto avevamo portato.
Non c’era musica. Del resto non ce ne sarebbe stato bisogno. Era tutta una voce, un chiacchiericcio, una risata, un tintinnio di brindisi, un richiamo delle donne a qualcuno che stava esagerando con il vino ed altre cose. Insomma un bel mondo riunito dove la pace e la solidarietà regnavano sovrani. Un mondo quasi perfetto mi sento di dire.
Noi sorvegliavamo che non nulla mancasse sulla tavola. Ne portavamo se vedevamo mancare qualcosa, tenevamo a bada i fuochisti nel loro dissentire, buttavamo un occhio nella stalletta dove erano richiusi i bambini. Vigilavamo e provvedevamo insomma alle varie incombenze, facendo nel contempo comunella con tutti, ma senza stare troppo con qualcuno in particolare.
Il sole nel suo tragitto scaldava le teste, le salamelle le gole, il vino le menti e quella tavolata era come un unico essere vivente che pulsava tutta la vitalità di questo mondo. E se dall’alto il buon Dio avesse avuto tempo di buttare giù un occhio credo non avrebbe rimpianto di avere creato quella specie che altre volte gli procurava grattacapi.
Alcuni ogni tanto, per ovvi motivi, dimostravano l’esigenza di utilizzare un bagno. La casa del Micio tuttavia ne era priva. O meglio non proprio priva ma quel locale che il Micio stava rimaneggiando, più che un bagno assomigliava alla pancia del Kursk dai tanti tubi che scaturivano da ogni dove e financo dal soffitto. Tantè che, quasi tutti, decidevano poi di servirsi del “bagno grande”, allontanandosi nei campi ad una distanza proporzionale al personale senso del pudore.
Poi, verso il secondo pomeriggio, placata l’ira delle gole, si alternavano – a gruppi o tutti insieme – momenti ludici di grande divertimento. Aveva dunque luogo la consueta partitella a carte a quel gioco originale che conosciamo solo noi e nel quale il Micio si vantava di essere campione. Vi succedevano, rigorosamente eseguiti in piedi e con spiccata enfasi, i canti alpini. Era quello il momento in cui generalmente i bambini venivano liberati dalla cattività. Quel momento non era stato scelto a caso. Sapevamo per esperienza che canti li avrebbero ammaliati. Ed infatti, appena aperto il chiavistello dello stabbio, invece di correre a perdifiato come caprette liberate e scalcianti, si sedevano intorno ai grandi ed ascoltavano i canti dei genitori come i marinai di Ulisse con le sirene.
Più avanti – negli anni dove i bambini si erano fatti adolescenti – si organizzava nell’erba circostante la partitella a pallone: Vecchi contro Giovani; dove i figli giocavano contro i padri e raramente ho visto terzini così accaniti sulle caviglie degli avversari. La partita finiva in due modi. O per sfinimento di una delle due parti – generalmente i vecchi – o perché i giovani improvvisamente si stufavano e smettevano di giocare coinvolti in altro. Ma si sa, l’animo giovanile è mutevole e nessuno mai se ne fece un problema; a meno che non si stesse soccombendo.
Specie negli anni di mezzo facevamo anche degli scherzi a coloro che non erano proprio addentro alla compagnia. Di solito, nel tardo pomeriggio quando le bottiglie vuote erano già in numero considerevole, organizzavamo una finta rissa. Cioè fingevamo, con un voluto pretesto, che la discussione si accendesse talmente tanto dal venire alle mani. Ci offendevamo, poi ci lanciavamo addosso qualche salamella presa da dentro il piatto o magari il contenuto di bicchiere di vino rosso fino ad avvicinarsi pericolosamente l’un l’altro per darsele di santa ragione.
Naturalmente era tutto finto e dopo qualche attimo di straniamento dei presenti palesavamo il nostro scherzo fra l’ilarità nostra ed il sollievo generale. Però – a dire il vero – un anno la situazione ci sfuggì un po’ di mano; e quella volta che un tizio mi ruppe una sedia di paglia sulla testa pensammo che forse era ora di smetterla con quella farsa; anche perché sembrava proprio vera. Mi ricordo che un anno due coppie di bulgari inviati alla festa da non so bene chi, pensando che la rissa li avrebbe di lì a poco coinvolti, fuggirono sgommando a bordo delle loro auto ribassate e nessuno più li rivide. E dire che il maschio balcanico – la cui somma dote non è proprio la dolcezza – non tende a spaventarsi per simili frangenti. Chissà, si vede che eravamo bravi attori.
Poco prima del calare della sera noi e pochi altri, abbandonato il resto sparso ancora alla tavola o in giro nell’aia, eravamo soliti entrare in quella specie di torretta di cui ti avevo accennato.
Così, per riposarci un poco dalle fatiche del giorno e tirare le prime conclusioni sull’andamento della giornata. Il maggio è solitamente foriero dei primi tepori ma non sono mancate volte in cui la primavera stentava a scaldare le membra e la temperatura non era da maniche corte.
Allora, dato che nella torretta esisteva un camino, lo si accendeva e il tepore della fiammella indulgeva alla riflessione. C’era una sedia a dondolo rimasuglio di chissà chi. Senza che ci fosse bisogno di dircelo nessuno ci si sedeva. Lasciavamo che La Vecchia, una volta entrato nella torretta, trovandola libera, ci si accomodasse. Allora gli mettevano un maglioncino sulle ginocchia e senza che lo si chiedesse sapevamo che di lì a poco ci avrebbe ancora una volta raccontato delle storie della sua vecchia compagnia, dei sotterranei di San Rocco, dell’oratorio, e di quando don Campari non si era svegliato per la messa di Natale. Erano tutte storie che conoscevamo a memoria, tanto che avremmo potuto raccontarle noi stessi, ma era sempre bello ascoltarle dalla voce della Vecchia.
Piano piano le persone, i gruppi, le famiglie come erano arrivate se ne andavano. Alcune ringraziando e con grandi convenevoli, altri senza lasciare traccia, nemmeno quella dell’obolo della contribuzione. Ma noi lo sapevamo che l’umanità riserva alcune sorprese e ciò non ha mai rappresentato un serio problema per le casse del primomaggio. Il Signore da il Signore toglie.
Era venuto il momento dove chi va va e chi non va avrebbe voluto rimanere lì per sempre. I rimasti quindi, calata l’oscurità e cessata l’attività della griglia, si ritiravano dentro le mura della casa.
C’era un forno, la farina la avevamo presa quindi qualcuno si inventava pizzaiolo. Dopo che si erano fatte le pagnotte di pasta esse venivano stese poi immediatamente condite con tutto ciò che era rimasto. Quindi potevi trovare pizze con nulla, pizza con solo pomodoro, pizza con ali di pollo e pizza col salame. L’unica pizza che non comparve mai fu la pizza con le patate.
E siccome naturalmente non si poteva aspettare la lievitazione esse venivano infornate immediatamente. Ora – è chiaro – se all’ingresso del forno esse avevano la parvenza della pizza, all’uscita erano più che altro schiacciatine o gallette da marinaio e necessitavano di una sana dentatura per esser apprezzate.
Tuttavia, bollenti e durissime, le pizze venivano divorate all’unisono e con gusto, specialmente da parte dei più piccoli.
Alla fine anche per gli irriducibili, dopo aver smontato e pulito tutto quanto, arrivava il momento di lasciare quel santuario dove si era festeggiato il primo maggio. Abbracciavamo il Micio e tutte le volte ci prometteva che l’anno seguente avremmo potuto gustare delle straordinarie patate grigliate. Le nostre auto, fra una nuvola di polvere, si allontanavano dalla corte lasciando dietro di sé il Micio, la casa e gli ultimi luccichii delle braci.
Il Primomaggio non lo facciamo più dal Micio da parecchio tempo. Però il Micio lo vediamo ancora. Una volta l’anno, in dicembre, la notte di Santa Lucia. Ma anche in quelle occasioni – amico mio – di patate non se ne sono mai viste; ma questa è un’altra storia…